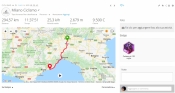Non è il giorno della Classicissima, non è neanche il giorno della randonnée e non è neanche il giorno della granfondo. Sabato 16 giugno può essere tranquillamente catalogato come giornata qualsiasi… Quasi per tutti.
Non per me, che alle 5.30 di mattina mi ritrovo a Milano, Chiesa Rossa, dove è posto il km 0 della gara dei professionisti.
«Ci sono vite che capitano e vite da capitano».
Già. Andiamo: all’inseguimento di un sogno, di un’ennesima follia.

Prendo la ciclabile che corre parallela alla statale dei Giovi. Non ci sono ali di folla ad attendermi e applaudirmi, ma schiere di conigli (ne conto più di 20) che rincasano dopo i bagordi del venerdì sera e qualche airone solitario. No, non Fausto. Lui sarebbe già in fuga.
Passo da Binasco, il paese dove vivo e da Pavia, mentre il sole si leva veloce e tiepido alle mie spalle.
Fino a Voghera una leggera brezza spira contraria, ma non dà fastidio.
A Ovada ha inizio la salita del passo del Turchino, punto più alto del tracciato con i suoi 532m di altitudine, posto a circa metà percorso. Da quel momento in poi, può cominciare il lungo conto alla rovescia.
Salgo spensierato, smanioso di arrivare in cima, quasi avessi appuntamento lì, quasi qualcuno mi stesse aspettando.
«Pazienta ancora un po’ e arriverò. Aspettami lassù».
Frammenti, emozioni, inspiegabili a parole.

Trafiggo la mitica galleria e poi la prima semicurva, da dove, per la prima volta vedo il mare. Finalmente. Arriviamo!
La discesa si esaurisce a Genova Voltri e da lì si imbocca, senza quasi mai lasciarla, la lunghissima Aurelia.
I paesi, che coincidono con le domeniche estive di chi il mare non ce l’ha a portata di sguardo, si susseguono come ostacoli di una lunga corsa. Già, perché quasi tutti sono custoditi gelosamente tra due collinette. Salite facili, pedalabili, ma che dopo 200km si sentono nelle gambe.
A tediare il mio incedere è però il vento, sempre più forte e insistente, che tenta di rispedirmi da dove sono venuto.
Sento le energie consumarsi con più velocità, quasi il mio serbatoio si fosse bucato. Tutto sommato però sto bene, procedo tranquillo… Almeno fino al km 231.
Esco dalla galleria che segna la fine di Albenga e improvvisamente qualcosa si inceppa. La luce si spegne. Mi fermo. Ho la sensazione di svenire da un momento all’altro. Lo stomaco impazzisce: non capisco se ho fame, sete, crampi o se devo vomitare. Crisi totale, senza alcun preavviso, senza alcuna soluzione.
Entro in paese, a piedi, bici a mano. Uno zombie. Sdraiato su una panchina, cerco di calmarmi, ma l’unico pensiero che mi rimbomba in testa è che questo sogno sta svanendo e non si realizzerà più. Ci tengo tantissimo e la delusione finisce per incrementare il malessere fisico.
Non sono uno che molla facilmente, di solito lotto fino all’ultimo, finché ne ho, ma in quel momento non sto neanche raschiando il fondo del barile: ho eroso anche quello.
È lì, in quel personale inferno racchiuso tra l’Aurelia e le onde del mare, che squilla il telefono. Una, due, tre volte. Appena riesco rispondo senza riuscire a vedere chi sia, anche se lo so. Dall’altra parte una farfalla che mi sfiora l’anima, che annulla la distanza che ci separa. Delicatamente mi prende le mani e mi rimette in piedi. Come? A parole, emozioni, mettendoci tutto ciò che è, che ha, ma questa parte, mi spiace, la tengo solo per me.
Non so ancora come, ma quella voce mi convince a risalire in sella e ripartire, dopo un’ora e mezza di stop forzato.
Mangio quel che posso, quel che trovo, quel che riesco. Il fisico non c’è più: gira a vuoto come un aeroplanino di carta lanciato distrattamente da un balcone.
Riesco a mantenermi sopra la soglia di sopravvivenza: basterebbe una folata appena più forte per farmi ricadere nell’abisso, ma senza che me ne accorga, con le sue ali, mi protegge anche da quello.
Al Km 240 mi attendono i tre capi, uno più severo dell’altro: Mele, Cervo e Berta. Me li lascio alle spalle mentre anche la testa si spegne. Non riesco più a pensare. Niente pensieri felici o tristi. Niente. Vado avanti solo col cuore. Tutto quello che mi rimane.
Km 267: mi attende la Cipressa. Salgo come un cadavere. ‘Uomo morto che pedala’. E allora di nuovo quella dolce farfalla a prendere tra le mani la mia anima e portarla su, fino in cima.
Manca solo il Poggio, ma sono talmente fuso e sfatto che sbaglio strada e salgo dal versante sbagliato. Salgo più di quel che dovrei per ritrovarmi all’imbocco dell’autostrada. Non ho il telepass, mi spiace, devo tornare indietro.
Ok, non sarà il versante giusto, ma il Poggio l’ho pur sempre fatto.
Mi ricongiungo all’Aurelia. Sanremo si materializza davanti a me dopo 295km e quasi 12 ore in sella. 15 con le pause. Fatico a crederci e non capisco bene cosa mi accada attorno. Trovo a malapena la forza di scattarmi una foto davanti al mare, prima che anche il cellulare si spenga con me.
«Oggi vinciamo noi».

Di tutta questa storia, di questo sogno che ha preso insperatamente forma quando tutto sembrava perduto, non rimarranno medaglie, non rimarranno diplomi, non rimarranno attestati. La strada disegnata dalle ruote si perderà nelle viscere dell’asfalto insieme alle mille storie di tutti coloro che sono passati di lì. Quello che resterà è un bellissimo e drammatico volo pindarico dall’inferno al paradiso, passando per l’Aurelia, sorretto dalle ali di una farfalla, senza la quale non ce l’avrei mai fatta. Always.